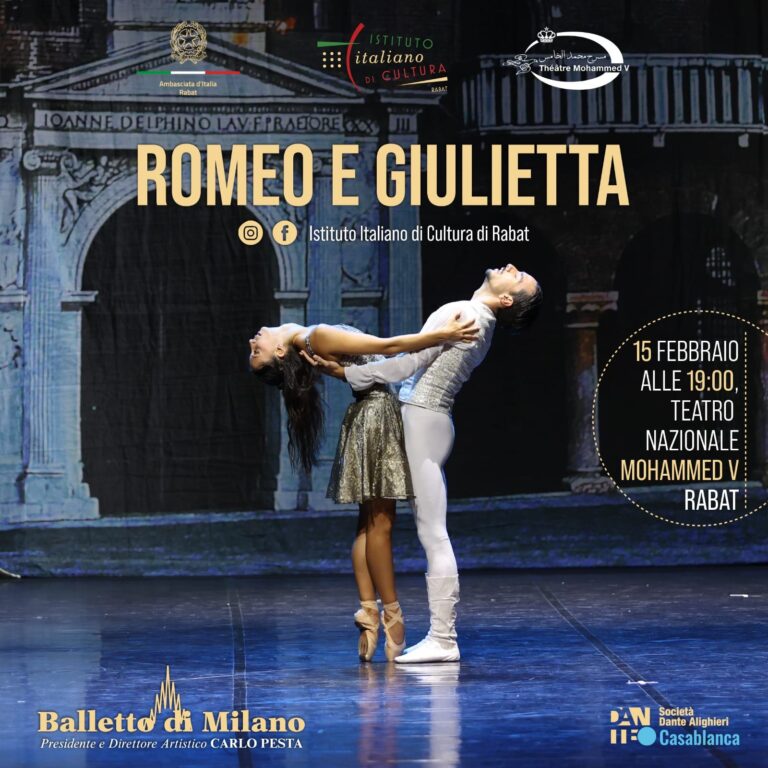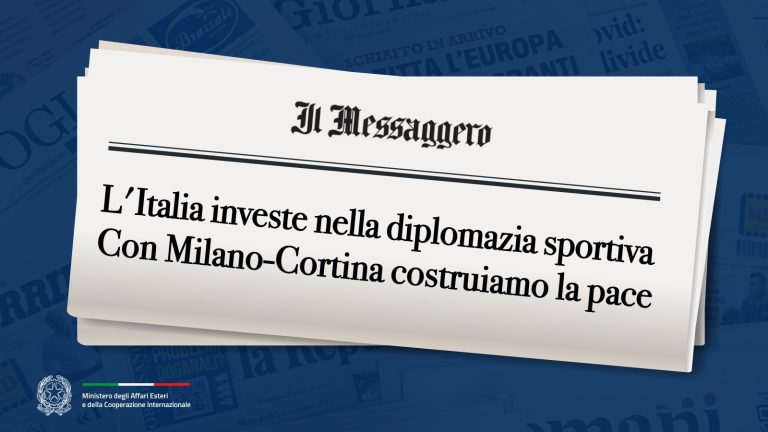L’alba delle relazioni italo-marocchine
(Il tempo del dialogo: due secoli di relazioni tra l’Italia e il Marocco)
Prendere la parola a Fès, nel cuore della memoria del Marocco e del pensiero mediterraneo, significa tornare all’alba delle relazioni tra l’Italia e il Marocco e riconoscere, in questo incontro, la continuità di un dialogo che attraversa i secoli.
Fès è una città che custodisce nella pietra e nella parola la saggezza del tempo.
Le sue mura, le sue scuole e la sua università portano un’eredità che non appartiene soltanto al Marocco, ma a tutto il Mediterraneo.
È per me un grande onore essere qui, in una città che più di ogni altra incarna la memoria viva e l’anima spirituale del Regno.
Ogni relazione tra Stati, come tra persone, nasce da un gesto di riconoscimento.
Il tempo la trasforma, ma la sua essenza resta.
Così è per il legame tra l’Italia e il Marocco: se oggi celebriamo due secoli di relazioni diplomatiche, è perché le loro radici affondano in una storia molto più antica, fatta di viaggi, di incontri e di scambi che precedono la diplomazia moderna.
Molto prima del 1825, le nostre due sponde avevano già imparato a conoscersi.
Nel Medioevo, navigatori e mercanti italiani solcavano queste acque, raggiungendo i porti di Safi, Salé, Anfa e Mogador.
Da Genova e Venezia, da Pisa, Napoli e Livorno partivano navi cariche non soltanto di merci, ma anche di parole, di idee e di curiosità.
Da Firenze, cuore dell’Umanesimo, giungevano studiosi, cartografi e artigiani attratti dalle scienze e dalle arti del mondo arabo.
E da Palermo, crocevia di civiltà, salpavano navigatori e religiosi che conoscevano le lingue e le rotte del Mediterraneo.
Ma anche da questi porti marocchini partivano viaggiatori, studiosi e mercanti portatori di un sapere raffinato, di uno spirito di dialogo e di una visione del mondo aperta sul Mediterraneo.
Tra le due rive si stabiliva così, molto prima della diplomazia moderna, uno scambio di conoscenze e di valori che ha radicato nel tempo una familiarità profonda.
Quegli scambi non erano soltanto commerciali: erano incontri tra donne e uomini uniti dallo stesso mare e dalla stessa vocazione al dialogo.
I cronisti dell’epoca ricordano lettere e ambascerie, scambi di doni, accordi marittimi e negoziati per la sicurezza delle rotte — segni di una consuetudine che, da secoli, precede la diplomazia moderna.
Su quelle rotte si formarono uomini capaci di comprendere entrambe le sponde: artigiani, interpreti, studiosi, religiosi.
Le città marinare italiane e i porti marocchini furono i primi laboratori di un Mediterraneo condiviso, dove la lingua del commercio si intrecciava con quella della cultura e del rispetto reciproco.
Era una diplomazia senza protocolli, ma con un linguaggio universale: quello della curiosità e della fiducia.
Da questa lunga consuetudine nacque, due secoli più tardi, la volontà di dare una forma duratura a un’amicizia già esistente.
Un’amicizia che il Trattato di Amicizia e di Commercio del 1825, concluso tra il Regno di Sardegna e il Sultanato del Marocco, consacrò nel rispetto reciproco e nel riconoscimento della sovranità di ciascuno.
Era un’epoca in cui il Mediterraneo era attraversato da tensioni, ma anche da diplomazie lungimiranti che vedevano nel mare non una frontiera, ma un ponte.
Quel trattato non nacque da interessi di potenza, ma da una scelta di fiducia.
Due Stati, consapevoli delle proprie differenze, decisero di riconoscersi e di dialogare.
L’Italia, che non era ancora unita, cercava in quel rapporto un canale di conoscenza verso il mondo arabo e africano; il Marocco, da parte sua, esercitava la propria sovranità dialogando da pari a pari con le potenze del tempo, fedele alla sua tradizione di indipendenza e di apertura.
In quell’accordo — sobrio ma visionario — furono gettate le basi di un’amicizia fondata non sulla forza, ma sul rispetto e sulla fiducia.
Quel legame aveva un valore politico, ma anche simbolico: due nazioni che si tendevano la mano in nome della cooperazione, anticipando una visione moderna del Mediterraneo come spazio di equilibrio e di scambio.
Era l’inizio di un tempo nuovo: l’alba di una relazione destinata a durare due secoli e a crescere al ritmo del mondo.
Cinquant’anni più tardi, nel 1875, la missione guidata da Luigi Scovasso giunse a Fès.
Fu un momento di alta importanza diplomatica: la prima ambasceria del giovane Regno d’Italia presso un Paese arabo e musulmano.
Il pittore Stefano Ussi ne immortalò la scena in un celebre quadro che illustra l’incontro di due mondi che non si temono, ma si riconoscono.
Tra i membri della missione figurava Edmondo De Amicis, che nel suo Marocco seppe raccontare quell’esperienza non come una curiosità esotica, ma come un dialogo tra civiltà fondato sul rispetto e sulla conoscenza reciproca.
La missione italiana attraversò il Paese con curiosità e rispetto.
I suoi membri descrissero la bellezza dei paesaggi, l’eleganza delle città, la saggezza delle tradizioni.
Fès appariva come un intreccio di voci e di colori, un crocevia di saperi, dove la diplomazia trovava un significato che andava oltre la politica: quello dell’incontro tra le culture.
Da quell’esperienza nacque una lezione destinata a durare: la vera diplomazia non si misura dai protocolli, ma dalla capacità di ascoltare, comprendere e condividere.
Fès, capitale del sapere e della spiritualità, accoglieva un’Italia che cercava di definirsi come una nazione aperta al mondo mediterraneo.
Da quell’incontro nacque una grammatica diplomatica che ancora oggi ispira le nostre relazioni: l’ascolto come forma di conoscenza, la cooperazione come strumento di pace, la cultura come linguaggio universale.
E Fès, con la sua antica tradizione di sapere, ci ricorda che la conoscenza è la prima forma di cooperazione tra i popoli — il punto di partenza di ogni vera diplomazia.
Le relazioni tra l’Italia e il Marocco hanno attraversato tutto il XX secolo mantenendo una notevole coerenza di spirito.
Anche mentre il mondo cambiava rapidamente, il legame umano e culturale tra i nostri Paesi restava intatto.
Generazioni di italiani e marocchini si sono incontrate nelle scuole, nei cantieri, nelle università, nei laboratori artistici e nelle imprese.
Sono stati insegnanti, architetti, medici, studenti, imprenditori, donne e uomini che, con discrezione e costanza, hanno contribuito a costruire un dialogo quotidiano fatto più di gesti che di parole.
È grazie a questa trama viva di relazioni che l’amicizia tra le nostre due nazioni non ha mai perso vitalità.
Le relazioni internazionali, quando si radicano nella società, diventano un patrimonio comune: non appartengono più ai governi, ma ai popoli che le incarnano.
Oggi, due secoli dopo, il Mediterraneo ci invita a immaginare un nuovo modello di cooperazione.
L’Italia e il Marocco condividono la stessa convinzione: il futuro non appartiene alle economie isolate, ma alle società capaci di collaborare.
In questo spirito si colloca anche il Piano Mattei per l’Africa, attraverso il quale l’Italia promuove una visione di co-sviluppo fondata su tre principi rivolti al futuro: la pari dignità, la formazione e lo sviluppo condiviso.
Questo piano si inserisce in una visione condivisa con i nostri partner africani e mediterranei, nella convinzione che lo sviluppo si costruisca solo insieme, nel rispetto reciproco e nella fiducia.
Il Piano Mattei non è un’iniziativa, ma un metodo: costruire insieme, nel rispetto delle priorità e delle aspirazioni di ciascun Paese partner.
È una proposta al tempo stesso politica e morale: condividere il valore della conoscenza, non esportare modelli; unire le sponde del Mediterraneo in una logica di partenariato e non di dipendenza.
Oggi il Mediterraneo non è soltanto una frontiera geografica: è un laboratorio del futuro.
Per l’Italia, posta al centro di questo mare, il Mediterraneo non è solo una dimensione, ma una missione: unire le sue due rive coniugando passato e futuro, dialogo e sviluppo. È la nostra identità e anche la nostra responsabilità.
Qui si incrociano le rotte dell’energia, della tecnologia, delle migrazioni e delle culture.
Ed è qui che si deciderà se il mondo saprà costruire un nuovo equilibrio fondato sulla cooperazione.
Nel solco della visione illuminata di Sua Maestà il Re Mohammed VI, il Marocco ha saputo coniugare identità e progresso, preservare la propria eredità proiettandola nel futuro.
È una visione che unisce le radici africane, l’apertura mediterranea e la vocazione atlantica del Regno, e che trova nell’Italia un partner attento e solidale.
È in questa sintesi tra tradizione e modernità che i nostri due Paesi trovano oggi la chiave di una collaborazione autenticamente mediterranea.
Oggi, i nostri due Paesi avanzano insieme, convinti che il loro dialogo possa ispirare un Mediterraneo più equilibrato e più solidale.
Il Mediterraneo non è soltanto un luogo: è un sistema di valori, una dimensione etica.
Da secoli è il crocevia di idee, di religioni e di commerci, ma anche di scoperte e di rinascite.
Oggi la sua stabilità e la sua prosperità dipendono dalla capacità delle nazioni che lo circondano di farne uno spazio di corresponsabilità e di fiducia reciproca.
L’Italia e il Marocco, per la loro storia e la loro posizione, possono essere i pilastri di questo equilibrio euro-mediterraneo, unendo le loro energie e le loro culture per promuovere la stabilità e lo sviluppo condiviso.
Non si tratta di tornare a un passato idealizzato, ma di costruire un futuro realistico, fondato sulla fiducia e sulla cooperazione.
E questo futuro avrà soprattutto bisogno dei giovani: studenti poliglotti, imprenditori aperti al mondo, ricercatori e artisti capaci di trasformare la conoscenza in dialogo.
Perché le relazioni tra i nostri Paesi non si misurano solo in dati economici, ma nel desiderio di imparare gli uni dagli altri, di scoprire nella differenza una parte di sé.
In un’epoca di transizioni — energetica, digitale, demografica — la vera sfida è fare in modo che la crescita sia anche giusta e che il progresso tecnologico non lasci indietro nessuno.
La cultura e la formazione saranno il linguaggio comune del Mediterraneo di domani.
Dopo secoli di storia condivisa, l’Italia e il Marocco dimostrano che la cooperazione tra le due sponde può essere un cammino concreto di prosperità e di dignità.
Fès, culla del sapere e della fede, ci ricorda che il dialogo non è mai un segno di debolezza, ma di forza: la forza della conoscenza, della memoria e della fiducia.
Perché il tempo del dialogo non appartiene al passato, ma al futuro: è il tempo in cui la diplomazia diventa cultura e la cultura politica della pace.
E forse questa è la più bella missione che la nostra epoca affida al Mediterraneo: continuare a parlarsi, a conoscersi, a riconoscersi.
Perché nel dialogo risiede la misura più alta della civiltà umana: la capacità di ascoltare senza paura e di costruire senza pregiudizi.